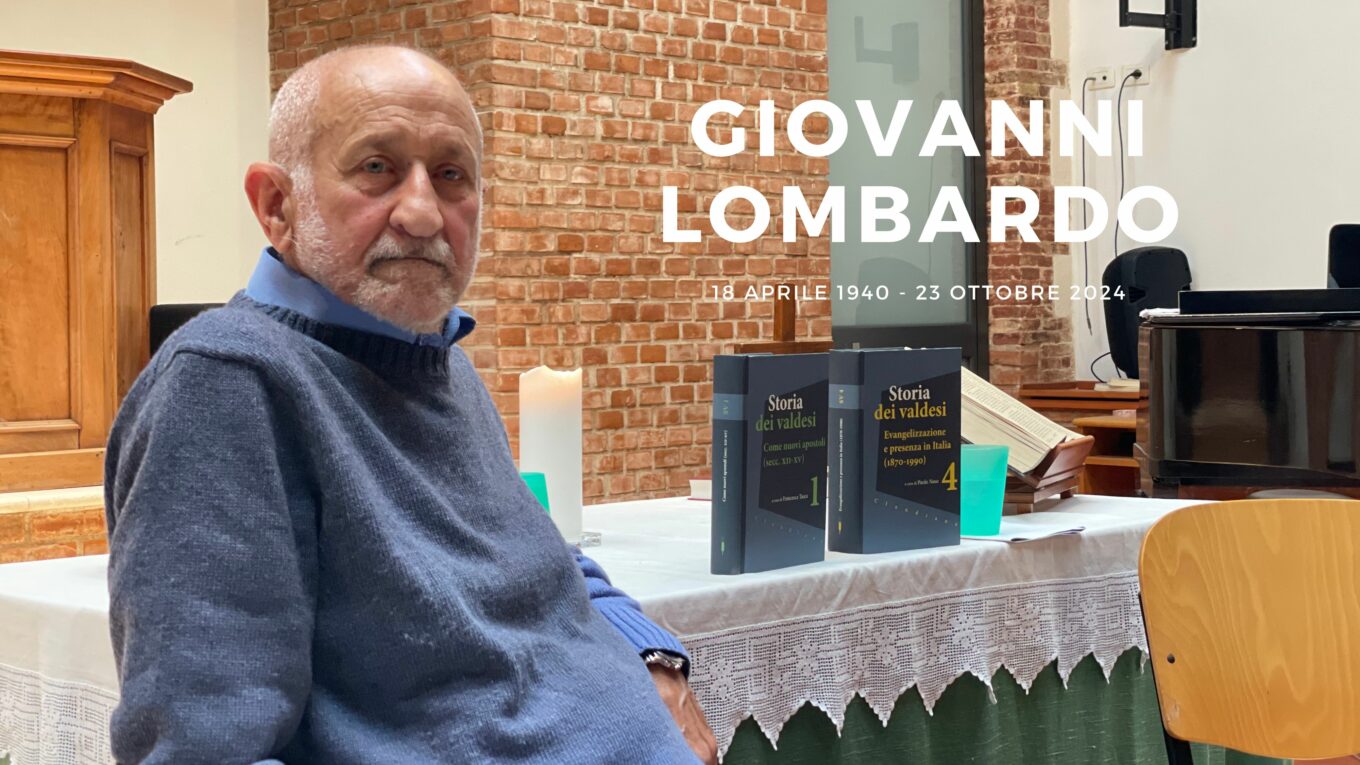Marsala, 28 ottobre 2024 – a cura di Gianluca Fiusco
Essi trasformeranno le loro spade in vomeri d’aratro, e le loro lance, in falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra, e non impareranno più la guerra.
Isaia 2, 4
Se dunque v’è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d’amore, se vi è qualche comunione di Spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, 2 rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. 3 Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso, 4 cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
Filippesi 2, 1-4
Care sorelle e cari fratelli,
dopo la scomparsa di Giovanni mi sono sentito sospeso. Non pienamente sulla terra ma anche un poco altrove. Sospeso tra il non più ed il non ancora. Cercando di afferrare ogni ricordo che, così vivido nei giorni prima, sembrava a quel punto scomparso. Cercando cioè di far prevalere la ragione sulla irragionevolezza della morte di una persona amata.
Nella scelta di questi due testi, riecheggia l’eco di questo travaglio.
Versi che a me pare racchiudano il senso profondo dell’esistenza di Giovanni. Da un lato l’impegno per la pace. Non una pace da parata, quanto la pace determinata dall’incontro, dal confronto, dalla condivisione, dalla giustizia.
La pace non come attesa della distruzione che la impone come atto finale, ma come premessa e possibilità sempre necessaria. Pace frutto dell’azione stessa di quell’umanità pure oggi così impegnata nelle guerre.
Ma soprattutto pace come conseguenza dell’apprendimento. Anzi, e di più, come l’arte dell’imparare così strettamente connessa ad un’altra arte, di cui Giovanni è stato testimone e maestro, quella dell’insegnare.
La pace, quindi come conseguenza dell’imparare a non fare la guerra. Imparare, dal latino parare cioè apparecchiare, mettere a disposizione dell’intelletto. Che richiede impegno a non fare più la guerra.
Ed il testo del nuovo testamento riferito a una delle lettere attribuite a Paolo alla comunità di Filippi.
I cristiani di questa città situata al nord Grecia, a una decina di chilometri dal mare, erano di provenienza pagana. Il tema di fondo che ispira tutta la lettera è l’incoraggiamento fraterno. Una solida amicizia lega Paolo a quella Comunità.
Ma c’è di più: questa amicizia, questo affetto reciproco nascono dal fatto che Paolo non rimprovera ai Filippesi la loro origine.
Il tono dello scritto, infatti, non si rivolge mai loro richiamando citazioni dall’antico testamento. Cioè Paolo non traccia mai un confine né una distanza determinati dalla conoscenza, dall’appartenenza religiosa e culturale.
Nella traduzione della lettera ai Filippesi dal greco si è operata una scelta che, tuttavia, non ci restituisce pienamente la bellezza del testo. Di un testo che potremmo definire sia ecumenico ma anche molto poco dogmatico. Cioè poco legato ad una visione confessionale o misterica della fede.
Anzi, a ben vedere, nel nostro testo la fede non compare affatto. Ma compaiono sentimenti molto umani quali amore, comunione, tenerezza, affetto, compassione.
Se vi è qualche conforto d’amore – dice Paolo – se vi è qualche comunione di Spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, 2 rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento.
È singolare questo fatto, non trovate? I testi di Paolo sono sempre molto densi di teologia, di riferimenti all’Antico testamento, di citazioni, ammonimenti, regole morali, etc…
Qui non troviamo nulla di tutto questo. Quanto l’invito a confutare l’amore reciproco, con l’affetto, la tenerezza, la compassione. Con quei sentimenti positivi che portano a coniugare la nostra esistenza non come qualcosa di inaccessibile al prossimo, ma come il bene in comune, messo a disposizione delle altre, degli altri.
Un invito laico, potremmo definirlo. A cercare il bene comune, a partire non da quel che soddisfa me, ma da quel che fa bene agli altri e alle altre.
A me è sembrato di rivedere Giovanni in queste parole. Nell’imparare a non fare più la guerra e a cercare il bene che unisce tutti e tutte: credenti e non credenti, laici e chierici, giovani e vecchi.
In questi giorni in cui più forte la commozione per la sua scomparsa si è fatta viva, ho avuto modo di leggere molte parole su Giovanni.
Amici e amiche, allievi, ex studenti e studentesse, colleghi e persone che definiremmo comuni. In ognuno dei commossi pensieri che ho letto hanno risuonato sempre alcune caratteristiche ben precise: Giovanni era una persona che ti accoglieva col sorriso, ti ascoltava con la mente, ti parlava con il cuore. Una persona buona, dotata di una regale umiltà, di una integrità ed una modestia che lo rendevano accessibile a tutti e tutte. Accessibile ma mai accondiscendente, quanto partecipe.
Ho preso in prestito allora, perchè anche per il “predicatore amico” è doloroso questo lutto, le parole di Antonio Tabucchi in un famoso inciso.
Sostiene Giovanni di averci incontrati tutti e tutte un giorno. Ma non un giorno qualsiasi. In una di quelle giornate d’estate. Una magnifica giornata d’estate, col sole che riscalda ed il vento che ci accarezza.
In luoghi sfavillanti di vita, con le giostre e i bimbi che giocano, i vecchi che si appisolano al sole.
Sostiene Giovanni di aver alzato lo sguardo dal suo taccuino, un poco sgualcito per essere stato costretto in una tasca e su cui tratteggiava la sua vita e, avendo incrociato il nostro, smesso di scrivere, aveva sorriso con garbo.
Uno di quei sorrisi leggeri, senza pretese diremmo. Che trasmettono cortesia e, al tempo stesso, ci invitano a ricambiare.
E così abbiamo fatto. Ricambiato il sorriso ci siamo avvicinati e lui, alzandosi dalla panchina, ci ha invitato a sederci accanto.
Sostiene Giovanni che tutto è iniziato così. Il sole, il vento, l’estate ed un sorriso. E quella panchina vicino alle giostre col vociare indistinto dei bambini a far da sottofondo.
Sostiene Giovanni che quel giorno, nell’incontro con ognuno e ognuna di noi, si era messo a pensare. E pensando, e ascoltando, le parole avevano preso forma e colore del mare. E poi del cielo fino all’orizzonte.
Sostiene Giovanni di ricordarsi i silenzi di ognuno e ognuna. Quelle parole appese alle labbra, incapaci di farsi suono che vibravano l’aria.
E lui, sostiene, le aveva raccolte tutte. Tutte, ma proprio tutte. E quel vocabolario silente si era poi lentamente ricomposto nei versi che, negli anni, ha scritto.
Sostiene ancora di essersi messo, improvvisamente, a camminare. Lungo i solchi della campagna, con noi di fianco. Di aver visto nuvole nere e sentito un grande frastuono come di guerra. Tanto potente che le zolle si scomponevano e quasi noi cadevamo per terra.
Sostiene il ricordo che, in quel preciso momento, le sue mani ci hanno afferrato e la sua voce si è fatta allora un potente segnale al quale la campagna, a perdita d’occhio, rispose con la parola PACE.
Sostiene Giovanni che, mentre giungeva il commiato si mise a pensare al futuro. Quell’andirivieni di preoccupazione si trasformò in una nuova speranza, in un nuovo orizzonte da raggiungere. Perché? Questo a Giovanni è impossibile dirlo. Perciò ha lasciato a noi di scoprirlo.
Amen